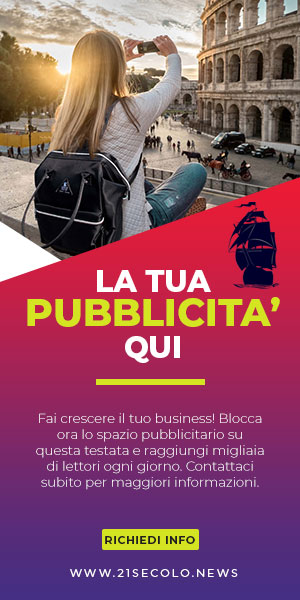Si va dipanando il mistero che avvolge il Tempio di Nettuno, il più famoso della Magna Grecia, situato nell’odierna Paestum (l’antica Poseidonia, in onore del dio Poseidone), a circa 30 km da Salerno.
I nuovi scavi, infatti, hanno avuto l’obiettivo di indagare sull’edificio che si trova al suo fianco, finora denominato “Casa dei Sacerdoti” in mancanza di definizioni accertate: si è cercato di capire quale fosse la funzione della struttura che risalirebbe alla “seconda vita” del tempio, quindi ai secoli IV-III a.C.
“Da lì è partita l’idea di avviare nuovi scavi in un complesso che, per la sua posizione accanto all’altare del tempio cosiddetto di Nettuno, deve aver avuto un’importanza centrale nelle attività rituali: speriamo così di avere nuovi dati sul contesto più ampio del tempio, anche perché non conosciamo ancora la divinità alla quale era dedicato. Sicuramente non era Nettuno, ma forse Apollo o Hera, o chi sa”, spiega il direttore degli scavi, Gabriel Zuchtriegel.
I risultati della prima fase delle operazioni conclusasi lo scorso 10 aprile, inducono a supporre che la costruzione – con un impianto irregolare e pavimenti in grandi basoli – possa essere datata tra IV e III sec. a.C., cioè tra la fase lucana e quella romana. “In quell’epoca – dice Zuchtriegel – c’erano ancora dei Greci a Paestum, ma chi comandava erano altri: prima i Lucani, poi i Romani. E con loro inizia quello che possiamo definire la ‘seconda vita dei templi’, i quali rimangono in uso, ma subiscono una rivisitazione. Non solo Hera diventa Giunone, Athena si ribattezza Minerva, ma anche la ritualità viene adattata ai nuovi patroni. Pare che la Casa dei Sacerdoti sia da inquadrare in questo processo di rivisitazione dell’antico santuario greco”.
Come portato alla luce dagli scavi, dopo la fase lucana e romana la Basilica subì una ristrutturazione e al suo interno fu chiuso un pozzo con resti di animali, probabilmente oggetto di sacrificio alle divinità, e il pavimento in bosoli fu ricoperto in diversi punti dal cocciopesto.
Gli archeologi stanno cercando di stabilire con esattezza, inoltre, quale fosse l’utilizzo di un focolare o un forno in cui si sono imbattuti (se servisse a cucinare, o a realizzare degli utensili) e la sua relazione con l’edificio: alcuni vecchi interventi, mai documentati, degli anni ’50 del secolo scorso hanno alterato la statigrafia, anche se “la presenza di un punto di fuoco non desterebbe stupore in un santuario antico, considerando che il sacrifico prevedeva il consumo di gran parte degli animali immolati presso l’altare”, spiega il funzionario archeologo Francesco Scelza.
“Ora però servono ulteriori fondi – annuncia Zuchtriegel – perché come spesso accade, lo scavo ha posto più domande di quante ne abbia risolte. Intanto ringrazio gli archeologi e gli operai che hanno lavorato sotto gli occhi di migliaia di ragazze e ragazzi che sono passati da lì. Abbiamo deciso di scavare pubblicamente, cioè senza schermature, con visite al cantiere ogni giorno per il pubblico presente negli scavi. È la sintesi della nostra missione: condividere la ricerca e la conoscenza con tutti”.