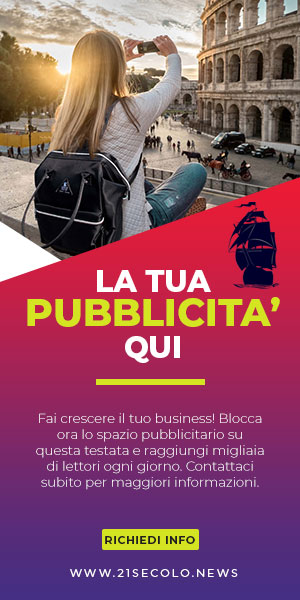L’ epiteto con cui viene apostrofato il generale del Regio Esercito Armando Diaz si allega alla tenacia con cui riorganizzò dopo la disfatta di Caporetto l’esercito italiano in una situazione amara sul fronte occidentale della Grande Guerra.
Nato a Napoli il 5 dicembre, precisamente nell’attuale via Correra, è figlio d’arme -padre ufficiale ingegnere del genio navale- e di lignaggio notabile – baroni Cecconi- ma subitamente trasferito all’Accademia Militare d’artiglieria di Torino, località che durante la formazione e l’incipit della carriera militare lo vedrà spostarsi tra Napoli e Firenze.
Il ruolo di Diaz è antecedente alla Grande Guerra, nell’età giolittiana si contraddistingue nella partecipazione coloniale in Libia sentita come revanche dello”schiaffo di Dogali” da parte delle frange nazionaliste italiani capeggiate da molteplici figure politiche e intellettuali quali Albertini, Moneta, ma anche i poeti Pascoli e d’Annunzio.
Con l’avvento delle “radiose giornate di maggio” e l’incipit alla guerra, cui lo stato maggiore italiano è capitanato da Luigi Cadorna, Diaz è generale di brigata addetto alle manovre senza disdegnare il campo di battaglia per scelta volontaria.
Viene infatti ferito nel 1917 alla spalla prima della disfatta di Caporetto, guadagnando la medaglia d’argento al valore militare.
Gli eventi del 1917 gli valsero la nomina sul campo e con una discrasia rispetto all’età di Cadorna da far inibire l’alto comando italiano.
Dall’8 novembre 1917 Diaz lavorò alla residenza del Piave e Monte Grappa, procedente alla riorganizzazione dell’assetto militare e bellico italiano.
Dalla mobilitazione della classe 99′, all’affiancamento di ufficiali quali Pietro Badoglio che avevano parimenti alla sua persona diretta conoscenza della trincea del Carso, stilò dispense presso il governo Orlando per nuovi equipaggiamenti come maschere antigas, autoveicoli per la dislocazione delle truppe e ulteriori investimenti per armamentari come lanciafiamme e rinvigorimento dell’arsenale.
Il ruolo di Diaz va anche ricordato per la capacità di rimettere in sesto lo spirito e il morale della truppa, non solo capeggiando le azioni ma anche avvalendosi di una capillare promozione patriottica dal tono retorico altisonante, capace di ridestare anche la nazione italiana in un momento di collasso sul fronte bellico quanto interno.
Ciò si evince dall’esito vincente su fronti ostici e in battaglie ardue come quella del Solstizio e Vittorio Veneto, fino alla capitolazione dell’Austria-Ungheria siglata il 4 novembre 1918.
Su ta versante incise anche la collaborazione al fronte data dal poeta-soldato Gabriele d’Annunzio, con operazioni dalla scarna valenza militare come il volo su Vienna e la beffa di Buccari ma dall’apporto simbolico cui Diaz colse prettamente la caratura morale.